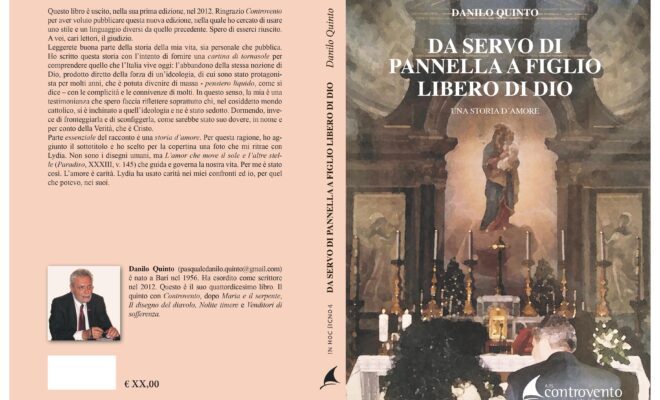Gloriosa Lucrezia
La gloriosa Università di Padova ha lanciato in questi giorni Lucrez-IA, l’intelligenza
artificiale a supporto della didattica dei suoi studenti.
Senza voler troppo addentarci nei tecnicismi dell’intelligenza artificiale, ci limitiamo a
descriverne alcuni pericolosi risvolti, peraltro denunciati dal medesimo sistema chatGPT
una volta interrogato sui pericoli che lui stesso potrebbe creare. Tra questi denuncia una
“totale perdita di controllo”, “l’automazione e la perdita di posti di lavoro”, “la
disinformazione e la manipolazione” dell’informazione attraverso cosiddette “fake news e
deep fake generate da algoritmi che potrebbero creare divisioni sociali e politiche” al
punto di destabilizzare democrazie, “la creazione di conflitti geopolitici e militari” ed infine
“implicazioni etiche” come decisioni importanti, tra le quali quelle “sanitarie, finanziarie o
legali” che vengono prese da algoritmi dei quali non possiamo avere la certezza che non
discriminino alcuni gruppi etnici o sociali. Ce ne sarebbe abbastanza per rifiutare qualsiasi interazione con tali tecnologie che, interrogate sulla loro pericolosità, si autodenunciano senza vergogna.
La notizia che una università italiana, e per di più tra le più prestigiose, voglia dotare il
proprio personale e soprattutto i propri studenti di una tale tecnologia non è per nulla
confortante.
L’università, ma anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, altro non è che una palestra
per allenare il cervello, per sviluppare neuroni e , sinapsi, le connessioni tra questi. Studiare,
insomma, altro non è che mettere in moto i nostri neuroni, allenarli al ragionamento
critico e alimentarli con sane e genuine informazioni e conoscenze. Il latino sàpere ha la
stessa radice dell’italiano sapore: il gusto cioè di conoscere e capire le cose, la realtà
che ci circonda, la storia che ci ha preceduto.
Se questo allenamento, se questo sapore buono della conoscenza viene affidato ad una
tecnologia che fornisce una risposta preconfezionata da una serie di algoritmi privi di
etica, i neuroni sclerotizzano, si bloccano, si atrofizzano e il gusto della curiosità della
conoscenza si trasforma in una “pappa pronta” insapore e gelatinosa, senza sostanza e
struttura. Peggio, diventa un cibo che non nutre, ma ammorba.
Conosciamo già i tristi risvolti di analfabetismo funzionale e cognitivo delle nuove
generazioni a cui questa tecnologia è stata fornita col biberon. Anche in questo senso la
IA si autodenuncia affermando che “l’adozione di tecnologie educative avanzate, come
l’IA, solleva interrogativi importanti riguardo gli effetti a lungo termine sulla capacità di
concentrazione, di memoria e di pensiero critico”. Tra questi menziona la “dipendenza
dalla tecnologia”, “il sovraccarico di informazioni”, “il declino della memoria a lungo
termine” con il cosiddetto Google effect, un fenomeno che descrive “come le persone
tendano a non memorizzare dettagli se sanno di poterli trovare facilmente online”, la
“mancanza di interazione sociale” con conseguente erosione di qualsivoglia pensiero
indipendente e creativo. Si definisce con il sinistro termine Demenza Digitale la perdita di capacità atrofizzate. Se digitate le parole demenza digitale su google arriverete a uno spaventoso numero di articoli, molti di alto livello scientifico, non solo di statistica ma di neuroscienze. Chi usa sistematicamente il navigatore perde il senso dell’orientamento. Chi non fa lo sforzo di memorizzare con prima filastrocche e poi poesie a memoria, con tabelline, date, nomi delle province del Piemonte e dei fiumi della Lombardia, i confini della Germania e la capitale dal Mali, perde la capacità di memorizzare. Chi non risolve problemi non sviluppa la capacità di risolverli. Lo spiegano con chiarezza Ricolfi e Mastrocola nel libro “Il danno scolastico”. A sempre più studenti non mancano solo le basi, le fondamenta della casa, manca la capacità di costruire.
In conclusione una perdita enorme delle capacità cognitive e del pensiero originale.
Che tutto ciò venga gioiosamente proposto nel luogo deputato alla creazione e allo
sviluppo di tali capacità è aberrante. A questo si aggiunge il danno da dopamina: detto in parole povere la tentazione che mangia il nostro tempo. Uno studente con un quaderno in mano, se si annoia, scarabocchia, oppure disegna, oppure scrive poesie o comincia un racconto. Ho cominciato a scrivere racconti sui quaderni di latino che all’epoca detestavo, mentre ora lo amo alla follia. Uno studente con un computer in mano quando si annoia va inevitabilmente su You tube, su Netflix e su You porn, con un disastro non sempre facilmente reversibile dei suoi neurotrasmettitori.
Per fare un esempio piuttosto comprensibile anche per un’intelligenza artificiale, studiare è come
se andassi in palestra, facessi fare tutto il lavoro muscolare e la fatica alla cyclette senza pedalare io con la pretesa di uscire e avere natiche e gambe di acciaio. Non funziona così.
Thomas Edison diceva che “genius is one percent inspiration and ninety-nine percent
perspiration”: cominciamo con la perspiration, la fatica, e vedrete che arriverà anche la inspiration, la ispirazione, dote sempre più rara ai tempi del piattume artificiale.
Ai miei tempi si andava all’università per sviluppare e allenare l’intelligenza naturale che
ci era stata data in dono dal Padreterno. Oggi pare che le università siano diventati dei
diplomifici, naturalmente con tanto di firma digitale del rettore sulla finta pergamena.
Nulla è più concreto, reale, aristotelico, nemmeno a Padova che nel XIV secolo vide
proprio il nascere di questa corrente filosofica con Albertino Mussato, Pietro d’Abano e
Marsilio da Padova, raggiungendo il massimo splendore con Jacopo Zabarella. Nessuno di loro
ha usato l’intelligenza artificiale, e nemmeno Elena Lucrezia Cornaro Piscopia la usò, la prima
donna laureata al mondo.
Lucrez_IA prende il nome proprio di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, laureata in filosofia (guarda caso discutendo due puncta di Aristotele) proprio all’Università di Padova nel 1678, oblata dell’ordine di San Benedetto. Nessuno ricorda mai la sua perspiration e fatica nello studio, nessuno ricorda mai i suoi neuroni naturali, la sua pietas cristiana. La si nomina solo in nome di un peloso femminismo e per assimilarla a un intelligenza artificiale. Giù le mani da Elena Lucrezia, giù le mani dai suoi, dai nostri neuroni, dalle nostre sinapsi e dai nostri neurotrasmettitori! Se con conoscete Elena Lucrezia Cornaro Piscopia leggete “La mia Elena Lucrezia. Ultimo monologo di una felice memoria”, di Benedetta De Mari, un libro incantevole che racconta la storia di una donna straordinaria, della sua sapienza, della sua umiltà e della sua magnifica fede.